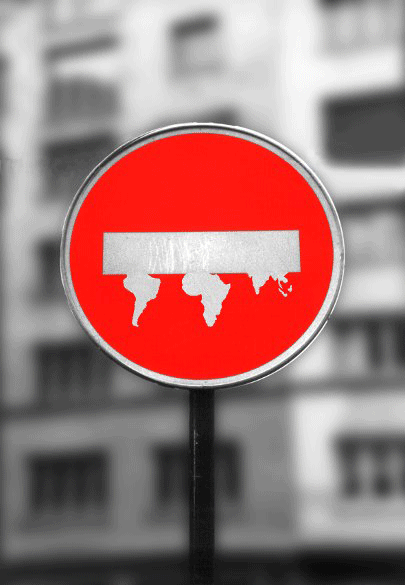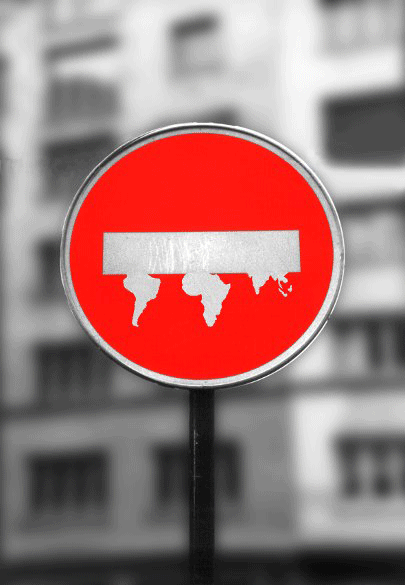
La si chiami “mondializzazione” o “globalizzazione”, l’universalizzazione capitalistica senza giri di frase o aggettivazioni evoca l’avvento di uno spazio planetario di mercato omogeneo, unico, di cui il cosmopolitismo liberista dei diritti dell’uomo costituisce l’espressione ideologica. È significativo che la Relazione annuale del Dipartimento di Stato americano sui diritti dell’uomo sia passata dalle 137 pagine del 1977 alle 6 000 del 2000. In compenso, è come se il concetto di imperialismo, che nel corso di tutto il XX secolo aveva svolto una duplice funzione analitica e strategica, fosse passato di moda con il disintegrarsi dell’Unione sovietica, e l’imperialismo come sistema di dominio e di dipendenze gerarchicamente strutturato si fosse dissolto nella mondializzazione. Alcuni cervelli di sinistra, che ieri si pensava funzionassero, hanno colto l’occasione dell’intervento Nato nei Balcani per buttare alle ortiche la cattiva coscienza dell’uomo bianco ed esaltare il magistero etico dell’Occidente vittorioso.
Il credo del nuovo cosmopolitismo liberista
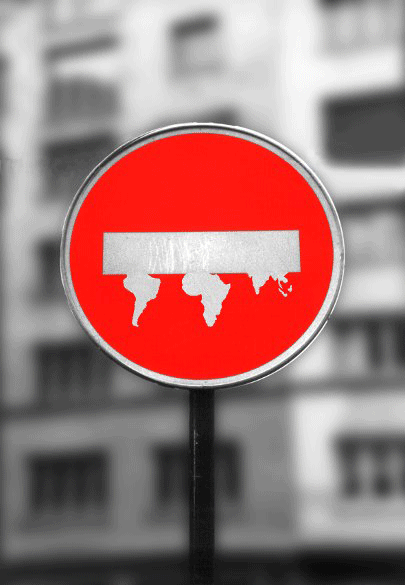 Un nuovo ordine imperiale?
Un nuovo ordine imperiale?
Ispirandosi a John Hobson e a Rudolf Hilferding, Lenin individuava nel moderno imperialismo la combinazione variabile di parecchi tratti tipici: la concentrazione e l’accentramento del capitale in forma di monopoli, la fusione tra capitale bancario e capitale industriale in un’oligarchia finanziaria, l’esportazione dei capitali, la formazione di cartelli internazionali, la spartizione territoriale del mondo. Di fronte ai mutamenti conseguenti alla Seconda guerra mondiale, alcuni autori hanno rimesso in discussione questa teoria. Essi sottolineavano come il capitale finanziario svolgesse ormai un ruolo meno importante della fusione organica tra grande capitale privato e Stato, come l’intervento di prodotti industriali sostitutivi rendesse relativo il saccheggio delle materie prime, come scemasse il diretto controllo dei territori con la decolonizzazione, e come le rivalità interimperialiste lasciassero il posto a relazioni pacifiche tra i paesi del centro. La loro contestazione privilegiava tuttavia alcuni tratti congiunturali della dominazione imperiale a danno della logica strutturale inerente all’accumulazione del capitale.
Se l’imperialismo si contraddistingue in genere per la sistematica appropriazione da parte di una nazione del valore creato da un’altra, la dominazione imperialista è la forma politica della mondializzazione capitalistica e del suo duplice movimento contraddittorio: di estensione spaziale del capitale su scala di un mercato mondiale senza frontiere, e di organizzazione territoriale dello sviluppo ineguale di cui gli Stati nazionali non rappresentano la forma finale. Perché il capitalismo non si potrebbe concepire come uno spirito economico puro? Come ha dimostrato Karl Polanyi, in La Grande trasformazione, il mercato non è una seconda natura parassitata da un ordinamento politico esterno, ma un’istituzione storica; e il capitalismo è inscindibile dai dispositivi istituzionali, tra cui gli apparati statali, che ne allargano la riproduzione. Lungi dall’imporsi come un naturale ritorno agli automatismi di mercato, la globalizzazione capitalistica è il risultato di una controriforma politica energicamente guidata dagli Stati dominanti, per imporre nuovi regimi istituzionali globalizzati nuove spartizioni territoriali, nuove norme commerciali e giuridiche internazionali.
L’imperialismo ha dunque conosciuto varie fasi: quella, sotto l’egemonia britannica, delle conquiste coloniali del XIX secolo (segnate dalla Guerra dell’oppio, dagli interventi in India, in Egitto, in Afghanistan; le spedizioni francesi in Algeria, in Messico, nel Tonkino, l’intervento americano a Cuba e l’annessione di un terzo del Messico; la grande spartizione dell’Africa, ecc.); quella dell’imperialismo moderno, analizzata alla vigilia della prima Guerra mondiale da Hobson, Hilferding, Bucharin, Lenin, contraddistinta dalla esportazione dei capitali, dal saccheggio delle materie prime e dalla fusione tra capitale industriale e capitale bancario; quella, successiva alla seconda Guerra mondiale, della guerra fredda, delle guerre di liberazione nazionale e della “decolonizzazione negoziata”, della Conferenza di Bandung dei paesi non allineati e dell’ideologia “dello sviluppo” della Cepal; infine, quella della globalizzazione in atto, che non dipende da un condizionamento tecnologico (internet e le telecomunicazioni), ma da un nuovo ordine conseguente alla controriforma liberista, alla disintegrazione del campo socialista, alle sconfitte sociali delle classi operaie occidentali alla fine degli anni settanta, allo smantellamento dello Stato sociale e al fallimento dei regimi populisti del Terzo mondo.
Partendo dalla contraddizione strutturale tra la mondializzazione dell’accumulazione e la sua territorializzazione statuale, Alex Callinicos distingue tre periodi nella fase imperialista del XX secolo, che traducono i mutati rapporti tra le tendenze contrastanti, tra l’organizzazione nazionale del capitale e il suo inserimento globale nel mercato mondiale: dal 1914 al 1945 predomina la statalizzazione del capitale, in un contesto di scontri militari tra la potenze imperiali che minacciano la sopravvivenza stessa del sistema; dal 1945 al 1973 le due tendenze si neutralizzano, nel quadro della prolungata espansione del dopoguerra e della spartizione del mondo sancita dalla guerra fredda; dal 1973 a oggi le tendenze alla globalizzazione del capitale predominano, in un contesto di ricorrenti recessioni e di crescente instabilità politica.
Secondo Samir Amin, la nuova dominazione imperiale si basa su cinque monopoli, di cui beneficiano i paesi del centro: sulle nuove tecnologie e sui brevetti; sul controllo dei flussi finanziari; sull’accesso alle risorse naturali; sulle armi di distruzione di massa; sui mezzi di comunicazione. Ne deriva una serie di nuove dominazioni, dallo “sviluppo del sottosviluppo” (o la ricaduta nel sottosviluppo) per intere regioni, fino allo sviluppo limitato e subordinato, nel quadro di una nuova divisione internazionale del lavoro (grazie alla quale i paesi dipendenti rispondono alle esigenze del centro, la cui rendita tecnologica garantisce l’accresciuta captazione del valore mondialmente prodotto). La sistematica appropriazione del plusvalore non avviene più solo tramite rapporti di dominazione bilaterali, ma anche globalmente, grazie all’intervento di istituzioni internazionali del governo mondiale quali la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale, o l’Organizzazione mondiale del commercio.
La controffensiva imperiale delineatasi fin dalla fine degli anni settanta, dopo la sconfitta in Vietnam, non è rigorosamente monetaria ed economica, ma si basa anche sulla corsa agli armamenti (e sull’egemonia militare americana) e sulle nuove strategie di intervento, cosiddette di bassa intensità, messe in atto nel corso degli anni ottanta in America centrale e nella regione dei Caraibi. Sono clamorose le conseguenze per l’America latina, per non parlare dell’Africa. Mentre questo continente rappresentava, nel 1950, il 14% del Pil mondiale, nel 1998 ne rappresentava l’8,8% (Brasile compreso). Mentre nel 1950 contribuiva per il 12% al commercio mondiale, nel 1998 vi contribuiva ormai per non più del 3,5%. Parallelamente, il debito estero è balzato da 79 miliardi di dollari nel 1975 ai 370 miliardi del 1982 e ai 750 del 1999. In 13 su 18 paesi, il salario medio nel 1999 era inferiore a quello del 1980. Tra il 1990 e il 1996, mentre le importazioni aumentavano del 127%, le esportazioni crescevano solo del 76%. Lo scarto tecnologico rispetto ai paesi del centro si è approfondito ulteriormente. Per effetto dei piani di aggiustamento strutturale imposti dal Fmi, con la relativa sequela di privatizzazioni e di deregolamentazione, la specializzazione e l’inserimento dipendente nell’economia mondiale si sono accentuati, con la soia che è per esempio diventata il principale prodotto di esportazione argentino. Alcuni autori parlano di ricolonizzazione altri di “ricompradorizzazione” delle classi dominanti locali. Occorre distinguere comunque una borghesia per la quale il mercato nazionale rimane determinante, come in Argentina e in Brasile, anche se i margini sono sempre più ristretti per un neopopulismo borghese, e una borghesia e una burocrazia “transnazionalizzate”, sempre più risucchiate dall’economia globale del mercato mondiale e dalla cooptazione istituzionale nella global gouvernance, con la conseguenza di una crescente autonomizzazione rispetto ai procedimenti di legittimazione popolare.
Se il dominio del dollaro e la dimostrazione della leadership militare americana nelle guerre del Golfo e dei Balcani hanno messo in evidenza il ruolo internazionale degli Stati Uniti, non significa per questo che l’Unione europea sia un mero vassallo o ausiliario. Essa rappresenta assolutamente un imperialismo concorrente, certamente alleato, ma anche potenzialmente concorrente. La denigrazione da parte dei mezzi di comunicazione di massa del vecchio “sovranismo” serve anche da copertura ideologica all’emergere di quello, alla dodicesima o venticinquesima potenza, della “potenza Europa”. La visione del mondo secondo la quale, anziché fondersi in un unico spazio, i territori si riorganizzerebbero in complessi regionali tende tra l’altro a cancellarne le rispettive differenze. È certo illusorio, come pretendono certi borghesi latinoamericani, presentare il Mercosur (ancorché alleato dei paesi del Patto andino) come un’alternativa subcontinentale alla zona di commercio delle Americhe voluta dagli Stati Uniti (con il zelante appoggio del Messico di Vincent Fox), di cui il Piano Colombia costituisce un risvolto militare per legittimare qualsiasi intervento presente e futuro. Ma sarebbe non meno sbagliato presentare il Mercosur, l’Unione europea o il Trattato di libero scambio nordatlantico come altrettanti complessi regionali equivalenti: lo sviluppo ineguale e la dipendenza esistono anche tra blocchi e regioni. Indice dell’ingiustizia planetaria, il rapporto tra i 20% più ricco e i 20% più povero della popolazione mondiale, che era di 30 a 1 nel 1960, è passato a 74 a 1 nel 1997. L’ora di lavoro del lavoratore americano medio, che si scambiava sul mercato mondiale con 40 ore di lavoro di un lavoratore indiano nel 1980, nel 1955 si scambiava con il doppio, e cioè con 80 ore. Grazie alla spirale del debito e al gap tecnologico, vent’anni di controriforma hanno notevolmente accentuato le differenziazioni e non reso il mondo omogeneo e pacificato, come i liberisti pretendono.
Pur traducendosi nell’avvento di un imperialismo senza nient’altro al di fuori, la mondializzazione imperiale non significa dunque l’avvento di un omogeneo spazio di mercato. Essa è – come sottolinea Samir Amin – di per sé polarizzante: lo sviluppo ineguale ne costituisce la legge immanente. L’imperialismo non è “lo stadio supremo del capitalismo”, ma l’ineluttabile conseguenza dello sviluppo ineguale e dell’accumulazione del capitale nel mercato mondiale.
“La questione dello spazio di accumulazione del capitale può porsi a vari livelli di astrazione”, scrivono gli autori di un recente articolo sulla periodizzazione del capitalismo. Ad esempio, il rapporto tra il sistema di produzione capitalistico e lo Stato nazionale è stato spesso concepito, a torto, non in termini storici, ma in quelli di esigenza logica e funzionale. La differenziazione spaziale non assume però necessariamente la forma esclusiva di una frammentazione statuale. Il rinnovato interesse nella sinistra radicale anglosassone per la produzione sociale dello spazio, o i lavori di David Harvey sulla geografia politica, insistono allora sulla necessità di ripensare le formazioni sociali indipendentemente dal loro esclusivo sviluppo nazionale.
Mentre, per Rosa Luxemburg, l’inclusione di nuovi territori e di nuove popolazioni era la condizione necessaria per il metabolismo del capitale, onde ristabilire l’equilibrio incessantemente spezzato dell’accumulazione, la novità inerente alla globalizzazione di mercato consisterebbe nel fatto che lo sviluppo ineguale ormai sarebbe non superato ma “introitato”. Tanto più esplosive sono le contraddizioni che ne derivano. Lungi dall’essere più armonioso, lo sviluppo diventa ancora più ineguale e peggio combinato, come dimostra la Relazione dell’Onu 2000, basata sull’indice di sviluppo umano. Anche se le componenti di questo indice restano discutibili, esso lascia scorgere l’approfondirsi di diseguaglianze non solo tra regioni del pianeta, ma in seno agli stessi paesi ricchi, e tra uomini e donne. Come all’epoca della mondializzazione analizzata da Marx sotto l’Inghilterra vittoriana e palmerstoniana, lo sviluppo dipendente non è un aspetto secondario o l’espressione di un ritardo rispetto all’accumulazione nei paesi cosiddetti avanzati. Resta la condizione stessa di questa accumulazione allargata, come la specializzazione dell’India, lo schiavismo coloniale e l’impiego dell’oppio costituirono il necessario risvolto della nascita del capitalismo industriale degli anni cinquanta e sessanta del XIX secolo.
Il mondo non è in vendita
Il nuovo ordine imperiale e i suoi tentativi di legittimazione sono bloccati da contraddizioni vecchie e nuove, gravide di nuove violenze e di nuovi disordini planetari.
1. La contraddizione tra la mobilità dei capitali e delle merci e il controllo dei flussi di manodopera, nel quadro di una nuova divisione internazionale del lavoro che tenta di ricavare il maggior vantaggio possibile dai differenziali di produttività del lavoro, onde trasferire il plusvalore verso i paesi a forte composizione organica del capitale e del lavoro. Tale contraddizione riveste anche la forma della contrapposizione tra la liberalizzazione dei mercati e la penalizzazione della sicurezza al livello sociale; o, ancora, tra l’apologia liberista di uno Stato sociale al livello minimo e la richiesta di uno Stato penale (militare e poliziesco) a quello massimo. Più in generale, sembra che gli Stati debbano più che mai assicurare le infrastrutture indispensabili per la riproduzione dei rapporti di produzione, garantire la sicurezza della proprietà, delle comunicazioni, degli scambi, e che nessuna istituzione internazionale sia in grado di assolvere tali funzioni in un prevedibile futuro.
L’ordine del capitale si basa quindi ancora su una molteplicità di Stati, la cui collaborazione nel quadro del “governo globale” non ne sostituisce le funzioni. In compenso, il ruolo di questi Stati è chiamato a trasformarsi, in quanto non sono più solo i garanti dei propri mercati interni, ma debbono consolidare sempre più i loro strumenti per garantire la riproduzione sociale e la proprietà al di là dei confini. Il rifiuto del più potente di essi, lo Stato americano, di piegarsi a un diritto commerciale (adozione di sanzioni unilaterali), giuridico (rifiuto di un tribunale penale internazionale), o ecologico (rifiuto della ratifica degli accordi di Kyoto) la dice lunga sul significato di un cosmopolitismo liberista a senso unico. Nel suo Grande Scacchiere, Zbigniew Brzezinsky riassume senza infiorettature la missione imperiale nel mondo: “I tre grandi imperativi della strategia geopolitica sono: prevenire la collusione dei vassalli e mantenerne la dipendenza in materia di sicurezza; vigilare sulla solvibilità dei debitori; impedire ai barbari di coalizzarsi”.
2. La contraddizione tra l’emergere di un ordine giuridico cosmopolita e di un ordine politico e militare che resta fondamentalmente interstatuale. I tribunali internazionali, la cui legittimità dipende dalle ratifiche nazionali, sono finanziati dagli Stati, o da donatori privati, laddove i contributi al funzionamento dell’Onu vengono concessi, legati a una sorta di elastico, soprattutto dagli Stati Uniti. La traduzione di Milosevic di fronte al Tribunale dell’Aia chiarisce i paradossi di questa giustizia a senso unico, in cui i paesi ricchi comprano l’estradizione dell’imputato, mentre altri criminali di guerra (per esempio i responsabili dell’agente chimico che ancora devasta il Vietnam, i mandanti politici delle torture in Algeria, oppure Ariel Sharon che viene ricevuto come un rispettabile alleato nelle capitali occidentali) godono delle indulgenze di una “giustizia internazionale” manipolata. L’equivoco alimentato accuratamente tra il diritto (giuridico) e il dovere (compassionevole) di ingerenza umanitaria illustra bene queste ambiguità. Dopo l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace a Medici senza Frontiere, l’ex presidente Rony Brauman e il presidente in carica Philippe Biberson denunciavano in una conferenza stampa la “ingannevole approssimazione di quel diritto”, nonché la “propaganda new age che trasforma una guerra in gesto umanitario”: “Lo slogan del diritto di ingerenza non si limita a presentare l’inconveniente di essere fallace, il che è già abbastanza per respingerlo: ponendo apparentemente sullo stesso piano Stati e Ong, getta su queste il legittimo sospetto che grava su quelli”.
3. Il “diritto del più debole” caro ad Alain Madelin si rivela dunque, nel mondo disegualitario realmente esistente, come la nuova maschera di giustizia del più forte. L’idea di una giustizia universale può esprimere l’aspirazione all’universalità a cui il periodo di decolonizzazione ha dato un impulso ancora attivo. Per il momento si tratta di un “fallimento del diritto”, ha detto Monique Chemillier-Gendreau. Apparsa tra il periodo della decolonizzazione e il crollo del Muro, la nozione di “patrimonio dell’umanità”, che riabilititava a partire dal diritto del mare le nozioni di jus nullius o di jus communis, si scontra con gli interessi degli Stati più potenti, sia che si tratti della ratifica degli accordi di Kyoto o della discussione sul diritto di inquinare. Il rapporto contrattuale determinato dai rapporti di forza, che domina sempre più il diritto comune nei rapporti tra gli Stati, come nel diritto privato va contro la nozione stessa di “patrimonio comune”.
Ciclostilato settembre 2001
www.danielbensaid.org